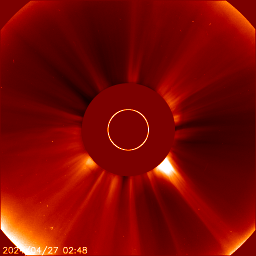Nella foto questo foro nero, del diametro di 65 metri, potrebbe essere una finestra di una caverna sotterranea sulla Luna. La foto, dal sito della JAXA, era stata scattata a maggio del 2008 e ritrae la regione denominata Marius Hill, situata sul lato visibile della Luna.
Sulla Luna sarà difficile, ma non impossibile, costruire un avamposto umano permanente, così come si vede frequentemente nei film di fantascienza. La mancanza di un’atmosfera protettiva però fa sì che la superficie sia direttamente soggetta alla perfida radiazione solare, per non parlare di una pioggia quasi continua di micrometeoriti: inoltre nel corso di un giorno lunare (che dura circa un mese terrestre) la sua temperatura subisce sbalzi di più di 200°C. Molti progettisti, nell’immaginare future installazioni umane sulla Luna, hanno quindi avanzato l’ipotesi di porre la colonia umana all’interno di un riparo (uno shelter), che le fornisca un’adeguata protezione ai pericoli provenienti dallo spazio (prima di tutto la radiazione) e la possibilità di isolamento a fronte di sbalzi termici così elevati.
Lo scavo di questo riparo potrebbe rivelarsi un progetto ingegneristico di fondamenatle rilevanza: la vita si semplificherebbe di parecchio se si trovassero sulla Luna delle caverne naturali. La Luna però non ha rocce calcaree del tipo terrestre, ma viceversa presenta un altro tipo di ambiente che potrebbe produrre caverne sotterranee: i tubi di lava (lava tubes). La Luna anticamente presentava una grande attività vulcanica, che aveva provocato la formazione di ruscelli sinuosi (rill) sulla sua superficie, alcuni dei quali potrebbero essere tubi lavici sotterranei come quelli che si formano ai fianchi del Vulcano Kilauea nelle isole Hawaii.
Quando la lava fluisce verso la superficie, si può raffreddare e solidificare in alto e può formare un tetto solido. Questo tetto isola la lava ancora liquida, che così è libera di continuare a circolare e che può scorrere lungo questi tubi ancora per parecchi chilometri. Alla fine dell’eruzione la lava può fuoriuscire completamente da questo tubo, lasciando al suo posto uno spazio vuoto che forma una caverna sotterranea.
Ma mentre parecchi ruscelli sono stati scoperti sulla Luna, nessuno mai ha confermato la presenza di un tubo lavico, con un tetto ancora intatto, che possa essere usato come riparo per gli esploratori umani. Uno studio, di C.Coombs e R.Hawke, ha ipotizzato che si possano trovare tubi intatti vicino ad altre sezioni collassate, ma la loro presenza non è mai stata confermata. Forse esistono parecchi tubi intatti, ma come fare a trovarli se sono nascosti?
La risposta è nella ricerca e scoperta di lucernari, fori neri nella superficie lunare, che sono aperture d’accesso a caverne sotterranee. Questi lucernari sono comuni sulla Terra e sono stati trovati pure sulla superficie di Marte (foto 1 e 2 fornite dalla sonda Mars Odissey), ma nonostante decine d’anni di ricerche nessuno ha ancora trovato un lucernario lunare. Almeno finora!

Gli innumerevoli coautori dell’articolo hanno esaminato le foto della sonda Kaguya relative ad un’area della Luna ricca di ruscelli, il complesso vulcanico delle Marius Hills. La loro ricerca di un vero e proprio ago in un pagliaio è stata premiata con la scoperta di un foro nero troppo profondo per essere un cratere da impatto: per la precisione questo foro è posizionato a 14.2°N e 303.3°E, proprio al centro di un piccolo ruscello (foto a fianco, effettuata dalla sonda Lunar Orbiter 4: il rettangolino indica la zona fotografata dalla sonda Kaguya). Questo foro è sostanzialmente circolare, con un diametro di 65 metri, ed è equidistante dalle pareti del ruscello, poste a 250 metri. Precedenti missioni lunari non l’avevano ancora fotografato con una risoluzione tale da evidenziarne la natura e da distinguerlo da un cratere da impatto.
La sonda Kaguya l’ha fotografato parecchie volte con vari strumenti a bordo, sia in alta che in bassa risoluzione, con condizioni differenti di illuminazione solare e da varie angolazioni. Semplici calcoli trigonometrici hanno permesso agli scienziati di determinare la profondità del foro da 80 a 88 metri, con pareti molto ripide. Il fatto che il foro è più profondo che largo è un sintomo che non si tratta di un cratere da impatto.
Ma si tratta proprio di un lucernario di una caverna? La sua collocazione proprio al centro di un ruscello è suggestiva, ma gli ambienti vulcanici hanno altre modalità di creazione di pozzi (pit), come ad esempio gli sfiati vulcanici. Nonostante queste considerazioni, gli autori hanno determinato che questa caratteristica lunare è proprio un lucernario di un tubo lavico sotterraneo: hanno pure stimato che la grotta sotterranea dovrebbe essere larga almeno 370 metri, uno spazio più che sufficiente per poterci lavorare all’interno!
Il team ha cercato altre aree simili nella regione, ma senza risultati e per quanto ne sappiano questo foro è appunto il primo mai trovato sulla Luna. Gli scienziati concludono dicendo che “Questa scoperta è importante per gli studi sulla vulcanologia lunare e sulla creazione di avamposti lunari umani. La zona delle Marius Hills è da tempo considerata un obiettivo d’esplorazione importante ed accessibile, sia dal punto di vista scientifico che tecnico. Ecco che, con la scoperta del foro nero cresce l’importanza delle Marius Hills come futuro obiettivo da esplorare”.
Ma forse questo foro non è proprio il posto adatto dove poter collocare una base permanente, dal momento che un sito con accesso ed uscita verticali (tramite una sorta di ascensore) potrebbe non essere ottimale. Magari sarebbe meglio poter entrare ed uscire da una grotta guidando un mezzo: l’ideale sarebbe quindi un tubo lavico intatto in vicinanza di uno collassato, con aperture direzionate verso nord o sud, in modo tale da non essere abbagliati dalla luce del Sole uscendo dalla grotta all’alba o al tramonto. In fondo è proprio la strategia utilizzata dai nostri progenitori cavernicoli quando cercavano una grotta dove poter abitare!
Carolyn van der Bogert, del team della sonda NASA LROC, aggiunge che hanno in serbo una lunga lista di obiettivi fotografati dalla sonda Kaguya da analizzare nuovamente in altissima risoluzione con la sonda LROC. Aggiunge che sicuramente fotograferanno pure questo foro nero sotto varie condizioni di luce incidente, per ottenere buone immagini sia delle pareti del foro che del pavimento sottostante. La sonda LROC è in grado di ottenere immagini con un livello di risoluzione pari a dieci volte quello della Kaguya!