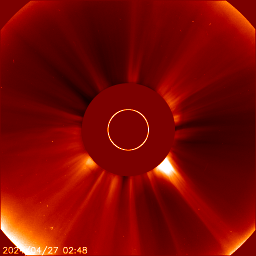Circa 2,4 miliardi di anni fa l’atmosfera terrestre subì il cosiddetto Grande evento di ossidazione (GEO), un drastico aumento nei livelli di ossigeno atmosferico. Si trattò, secondo le attuali conoscenze, di un punto di svolta nella storia naturale del pianeta, che aprì la strada allo sviluppo di forme di vita complesse.
In questo quadro rimangono tuttavia irrisolte due questioni: quando cominciò la produzione di ossigeno tramite fotosintesi e quando essa cominciò ad alterare la chimica dell’oceano e dell’atmosfera.
Ora una nuova ricerca guidata da un gruppo di geologi dell’Università della California a Riverside corrobora l’ipotesi che la produzione di ossigeno cominciò nell’oceano almeno 100 milioni di anni prima del GEO, e consente di dimostrare almeno in parte come anche basse concentrazioni di ossigeno possano avere profondi effetti sulla chimica dell’oceano.
Per arrivare ai risultati, i ricercatori hanno analizzato alcuni campioni di argilliti nere provenienti dall’Australia occidentale, che rappresentano essenzialmente resti fossilizzati di un antico fondale marino. La fine successione degli strati al suo interno infatti consente di ricostruire la storia evolutiva della chimica oceanica.
In particolare, le argilliti hanno rivelato che episodi di accumulo di solfuro d’idrogeno nelle profondità oceaniche in acque prive di ossigeno avvennero all’incirca 100 milioni di anni prima del GEO, vale a dire fino a 700 milioni di anni prima di quando previsto dai precedenti modelli della chimica dell’oceano primordiale.
Come sottolineano i ricercatori, la presenza di solfuro d’idrogeno nell’oceano è considerata una firma inequivocabile della produzione fotosintetica di ossigeno 2,5 miliardi di anni fa.
"L'emergere di una fotosintesi pre-GEO è oggetto di un intenso dibattito, e la sua soluzione consentirebbe una comprensione più profonda dell'evoluzione di diverse forme di vita”, ha commentato Timothy Lyons, docente di biochimica dell'UCR e coautore dell'articolo apparso sulla rivista “Science”. "I nostri dati mostrano la presenza di una produzione di ossigeno per via fotosintetica ben prima che le concentrazioni atmosferiche di questo gas raggiungessero una minima percentuale di quelle attuali, il che lascia supporre che le reazioni chimiche che consumano ossigeno controbilanciassero la produzione di questo gas”.
I ricercatori così ipotizzano che la presenza di piccole quantità di ossigeno abbia stimolato la prima evoluzione delle cellule eucariotiche milioni di anni prima del GEO.
"Questa produzione di ossigeno iniziale ha posto le basi per lo sviluppo di specie animali avvenuta almeno due miliardi di anni dopo”, ha concluso Lyons.